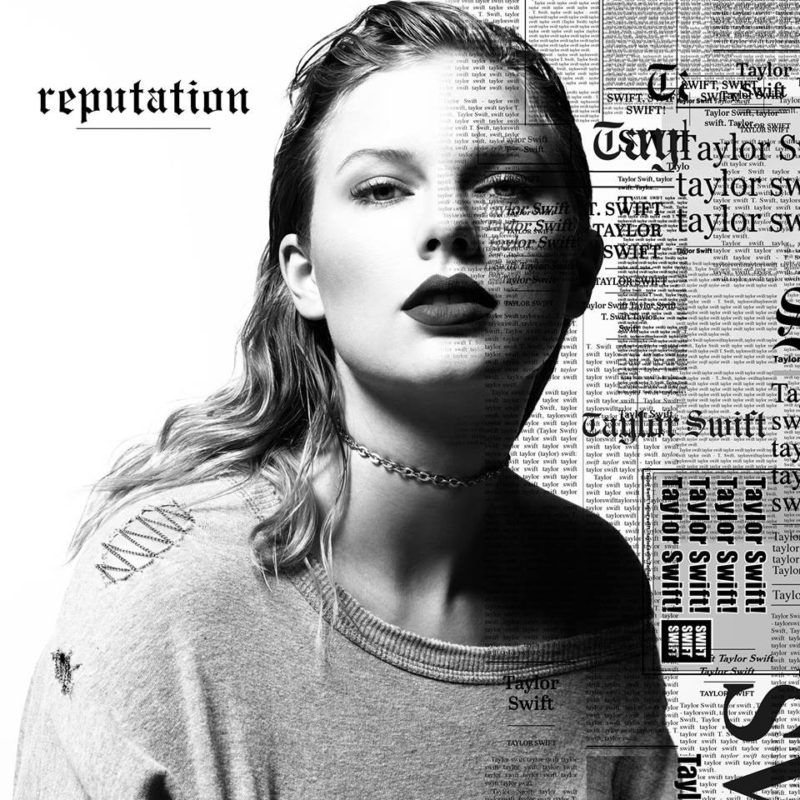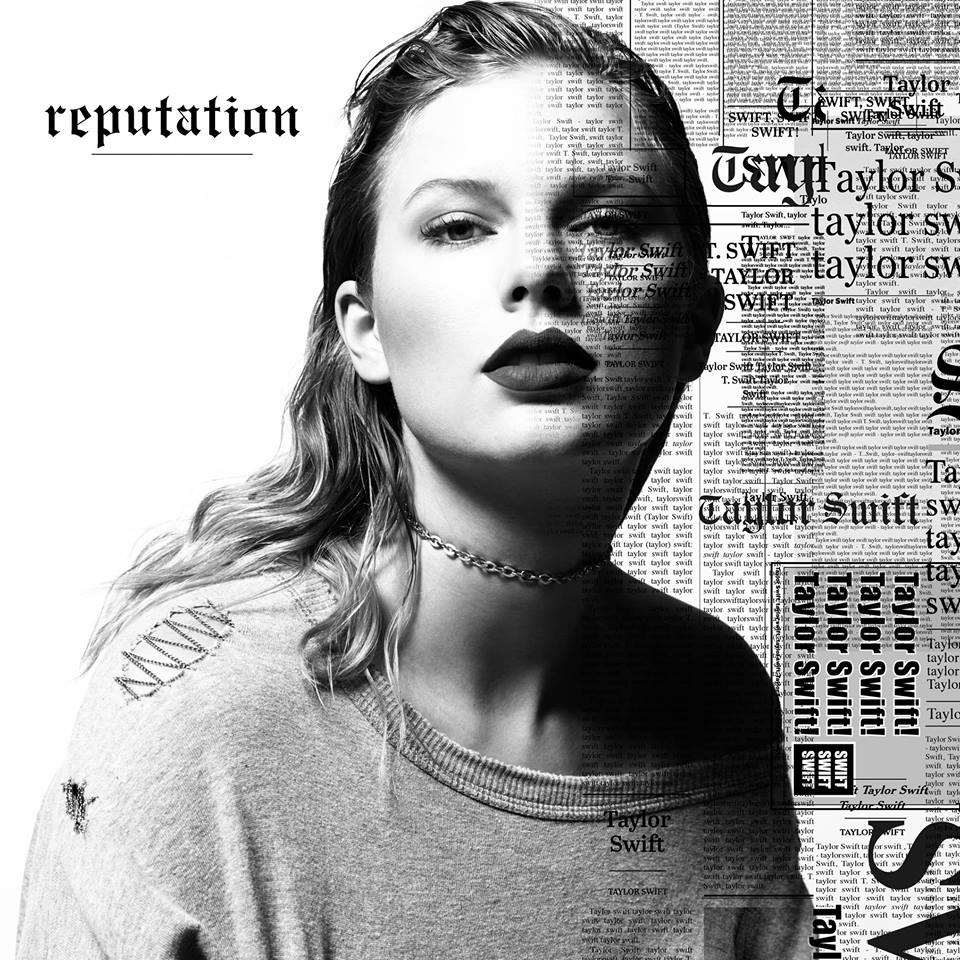“143”, perché l’ultimo album di Katy Perry non funziona?

Nel momento in cui scrivo, 143, ultima fatica discografica di Katy Perry, non ha ancora fatto la sua comparsa nelle classifiche, ma le previsioni del debutto sono tutt’altro che rosee.
Diciamocelo però, un po’ lo sapevamo: o Katy tirava fuori l’album del millennio, capace di risollevarle la carriera, oppure il destino del disco era già segnato ancora prima della sua pubblicazione. Colpa, purtroppo, dei due precedenti album, Witness (2017) e Smile (2020), non esattamente campioni di vendite, che hanno appannato l’aura di invincibilità di cui la Perry si era circondata nei primi anni ’10, ai tempi di Teenage Dream (2010) e Prism (2013). Due album fortissimi, che le hanno fatto guadagnare record su record. Basti ricordare che grazie ai singoli estratti da Teenage Dream, Katy Perry è stata l’unica artista – al pari di Michael Jackson – ad aver piazzato 5 canzoni dello stesso album al vertice della classifica americana. E poi sono arrivati, Roar e Dark Horses, estratti da Prism, entrambi certificati diamante negli USA.
Insomma, fino a una decina di anni fa Katy Perry sembrava l’incarnazione terrena del pop, l’artista capace di mettere d’accordo tutti. Se Madonna iniziava a perdere appeal sul pubblico più giovane, Britney e Christina erano in una fase calante della carriera, Lady Gaga destabilizzava con i look eccessivi e le scelte musicali non sempre digeribilissime (vedi alla voce Artpop), Katy era tutto ciò che al pop si poteva chiedere: canzoni super catchy e immagine rassicurante.

Poi, dicevo, è arrivato Witness, e quel magico mondo fatto di colori pastello e suoni zuccherati ha perso il suo mordente. Peggio ancora è andata a Smile, tre anni più tardi. Si potrebbe star qui ad analizzare il perché di quella débâcle, ma sarebbe un esercizio inutile. Accontentiamoci di sapere che è andata così.
Lo scorso luglio, a distanza di 4 anni, Katy torna è tornata, e ovviamente la notizia del suo comeback ha fatto tremare i muri e nutrito le aspettative. Aspettative che si sono però afflosciate come un sufflè malriuscito non appena è stato pubblicato il singolo della nuova era discografica, Woman’s World. Una canzone mediocre e facilona, che oggi troverebbe forse la sua giusta collocazione nel disco di qualche emergente. Invece è stato il brano di punta per il lancio del nuovo progetto. Catastrofe…
Troppo scontato, troppo semplice, troppo sfacciatamente ruffiano; e non è bastato neanche il messaggio femminista, davvero troppo annacquato per il mercato discografico del 2024.
La scelta di pubblicare in fretta e furia un secondo singolo (Lifetimes) e poi un terzo (I’m His, He is Mine) in poco più di un mese è stata la famosa pezza che ha fatto più danni del buco.
Troppo evidente la necessità di correre ai ripari, ma niente da fare, i due brani sono passati praticamente inosservati.
Restava da sperare che il resto fosse migliore.
Ora che l’album è uscito, possiamo tirare le somme, e capire perché poteva essere – e probabilmente sarà – un altro flop.
Molto semplicemente, 143 è un disco anonimo e superficiale. Un album che sembra essere rimasto fermo al 2013: forse per non correre rischi, Katy Perry ha scelto di riproporre le stessa ricetta che l’ha portata alla gloria. Peccato che siano passati più di 10 anni da allora, e che le cose siano cambiate un po’.
Prima di tutto, ci si augura che il pubblico che seguiva Katy anni fa sia cresciuto insieme a lei, e oggi si aspetti qualcosa di più maturo. E poi in questi anni il mondo del pop è stato rivoluzionato: solo per restare nell’universo femminile, sono arrivate creature come Billie Eilish e Taylor Swift (che nel 2013 esisteva già, ma era pressochè “confinata” al country) che ci hanno mostrato che si può essere pop e mainstream senza puntare tutto sulla semplicità. Non che loro siano state innovative in questo, ma sicuramente hanno abituato il pubblico di oggi a un ascolto diverso.
Presentato come un disco celebrativo dell’amore fin dal titolo – 143 sarebbe una forma in codice di “I love you”, sai che roba… – il settimo lavoro di Katy Perry si rivela essere una raccolta di pezzi buoni per ballare una sera, può essere la colonna sonora di un pigiama party, ma non è, oggi, quello che ci si aspetta da un nome del suo calibro.
I suoni pescano a pienissime mani dalla dance degli anni ’90 (I’m His, He’s Mine contiene anche un sample di Gypsy Woman, successo house del 1991), e questo poteva essere un buonissimo fil rouge. Ma oltre c’è ben poco di scoprire.
La sensazione è Katy Perry si sia fatta contagiare dalla sindrome di Peter Pan, e sia rimasta incagliata in una sorta di eterna giovinezza, convinta che dare ai fan un nuovo carico di canzoni-confetto sarebbe bastato ad accendere il loro entusiasmo come in passato. Ma così non è stato.
Quello che è mancato è stato prima di tutto la voglia di cambiare, evolversi, far vedere di essere altro rispetto a quello che tutti già conoscevano; e poi è mancato il coraggio di alzare la famosa asticella.
Intendiamoci, non tutto quello che è in 143 è da cestinare: Crush per esempio è un buon pezzo, ed è uno dei pochi che si fanno ricordare (anche qui c’è stata una ripresa dal passato, da My Heart Goes Boom). Così come non sono male Nirvana e Wonder. Ma tre pezzi passabili non sono abbastanza a fare un buon disco.
Infine, una considerazione a margine: tra le critiche mosse all’album vi sono state anche quelle di chi ha biasimato la scelta della Perry di lavorare con Dr. Luke, figura assai controversa nel musicbiz per via della vicenda processuale che lo ha visto coinvolto dopo le accuse mosse da Kesha.
Senza entrare nel merito della questione, sono abbastanza sicuro che il tallone d’Achille del disco abbia ben poco a che spartire con la condotta morale di Dr.Luke.
143 è un disco mediocre, punto e basta.