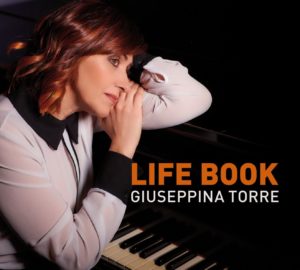BITS-CHAT: Distinguersi per riconoscersi. Quattro chiacchiere con… Arashi
Partire dalla provincia verso la grande metropoli per raggiungere un sogno, quello della musica.
Partire dalla provincia verso la grande metropoli per scoprire se stessi, conoscersi davvero forse per la prima volta, e nel frattempo affrontare l’ignoto, sperimentare la paura e imparare a farsi strada con la propria voce.
Quella di Arashi è una storia comune a tanti giovani artisti, ma dalle sue parole assume soprattutto i contorni di un vero processo di formazione personale, oltre che artistico. Originario di Alessandria, Riccardo Schiara – questo il suo vero nome – è arrivato a Milano nel 2015, iniziando da subito a prendere contatto con l’ambiente musicale della città. Dopo le prime produzioni all’insegna dell’elettronica, lo scorso gennaio ha pubblicato Spiagge adriatiche, un EP con cui si è avvicinato alle sonorità dell’r’n’b e del soul.
Sempre con un obiettivo in testa: imparare a riconoscersi in mezzo a tutto il resto.

Le spiagge adriatiche sono un luogo dell’anima?
Sono ciò che ci rappresenta e ci identifica. Se ripenso al passato, ma anche alla nostalgia per qualcosa che deve ancora essere, mi ritornano in mente le immagini di quei luoghi che ho frequentato da piccolo con la mia famiglia, e che per me sono simbolo di pace, sicurezza, libertà, forse perché sulla spiaggia lo spazio si dilata. L’intenzione che avevo con i brani dell’EP era proprio quella di comunicare questo senso di tranquillità, serenità.
Personalmente, ho trovato il mood dell’EP molto variegato, con momenti di libertà e di gioia che lasciano il posto alla malinconia. Che definizione daresti dal mood di Spiagge adriatiche?
Fin dall’inizio ho immaginato l’EP come un percorso: si parte da Incubo, la traccia più spensierata, surreale e più ingenua, è la visione di un ragazzo che non si è ancora confrontato con la vita; Angeli invece è lo sgretolarsi della realtà sognante e idilliaca. Tutto l’EP è il risultato delle esperienze che ho fatto fino ad oggi.
L’EP ha solo quattro tracce, una scelta precisa?
Ho scritto tanto, ma ho preferito includere solo queste, sono quelle che al momento mi rappresentano di più. Continuo comunque sempre a scrivere e qualcosa farò anche con gli altri pezzi.
Nessuno dei pezzi arriva ai classici 3 minuti.
Non è stato un calcolo, semplicemente in ogni traccia il messaggio è concentrato in quel minutaggio e mi sembrava di snaturare la scrittura se avessi allungato. Oggi i 3 minuti canonici non sono più una regola, c’è molta libertà, si può scrivere una canzone di 2 minuti o una di 10 senza problemi.
Dall’elettronica di Sud America e Fiori rossi ai suoni di Spiagge adriatiche sembra esserci un po’ di distanza. Cos’è cambiato in questi anni?
Quando ho cominciato a fare musica ero molto piccolo, mi sentivo inesperto, ero un novellino di 19 anni appena arrivato a Milano. Ho iniziato a guardarmi un po’ intorno e a sperimentare: mi sono subito trovato molto bene con Marcello Grilli, che ha prodotto i miei primi pezzi, Sud America, Fiori rossi e Parka. Avevo un’urgenza di scrittura diversa, sono cresciuto, e con me sono cambiati anche i suoni dei miei pezzi. Milano mi ha dato la possibilità di confrontarmi a fondo con l’ambiente musicale, e questo mi ha permesso di far crescere il mio progetto, dall’elettronica sono passato agli strumenti veri. Per Spiagge adriatiche mi sono affidato a Marco Maiole, con cui ho sentito da subito una grande intesa, mi sono innamorato del suono della sua chitarra. Cerco sempre di ascoltare molto le persone chi mi stanno intorno, e questo sicuramente ha portato a migliorarmi, anche se non penso di essermi allontanato molto dal pop.

Senti molto l’influenza di Milano?
Ho imparato ad apprezzarla negli ultimi due anni. Sono molto timido, non mi piace raccontare tanto di me stesso, e Milano mi dava l’impressione di una città in cui contava soprattutto l’apparire. Venivo dalla provincia e ho fatto fatica a trovare un posto che potessi davvero sentire come casa, poi l’ho conosciuta meglio, ho interagito con altri musicisti e ho iniziato a cogliere le tante opportunità offerte ai giovani artisti e le tante occasioni per mettersi alla prova. È stato un percorso difficile, ma oggi posso dire di sentirmi finalmente rappresentato da Milano.
A Milano hai conosciuto anche Mahmood.
Sì, io e Ale siamo amici da un sacco di tempo. Insieme a Camilla Magli, un’altra musicista che fa parte del nostro giro di frequentazioni, ci troviamo spesso a scrivere e a parlare di musica. Non abbiamo però mai davvero pensato a una collaborazione, l’idea di lavorare insieme ci sembrerebbe strana. Sarebbe come pensare di dover lavorare insieme al tuo migliore amico.
In Manifesto dici “Non lasciarmi solo”. Che rapporto hai con la solitudine?
Nella canzone mi sono immaginato un dialogo con me stesso. Sto bene da solo, amo ritagliarmi i miei spazi, e quando devo scrivere mi distraggo se ho altre persone attorno. Stare da solo è quasi una necessità a volte, anche se non sono un eremita.
Sogni qualche collaborazione in futuro?
Penso a nomi fuori dall’Italia nell’ambito del funk e dell’elettronica, per esempio Toro y Moi o Róisín Murphy, che mi piace molto per il mood delle sue produzioni elettroniche.

Cosa significa crescere?
Oggi, a 25 anni, crescere vuol dire soprattutto crearmi un’ideologia che mi rappresenti e sia coerente con la mia personalità; formarmi e riconoscermi per ciò che sono, senza ambizioni estranee e senza farmi influenzare dall’esterno. Non è sempre facile capire cosa vogliamo davvero e cosa invece ci viene imposto: l’obiettivo più difficile è proprio quello di riconoscersi in mezzo a tutto il resto.
Concludo con una domanda di rito per BitsRebel: che significato dai al concetto di “ribellione”?
Non definirsi in base a ciò che è sempre stato, perché non è vero che ciò che è sempre stato è necessariamente giusto. Siamo in un periodo storico in cui vediamo entrare in crisi valori che sono sempre stati alla base della nostra cultura: ribellarsi significa andare al di là di ogni definizione.